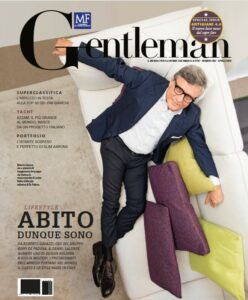Nessuno mai come Slim Aarons è riuscito a fermare la felicità, a fotografare un istante perfetto, immune al tempo. Ma quanto reale? forse nel Metaverso.

Vivere una vita felice, al riparo del dolore, sapere apprezzare i piaceri giusti nel modo giusto, è difficilissimo. «Proprio perché il piacere è il nostro bene più importante ed innato, noi non cerchiamo qualsiasi piacere», scriveva Epicuro. Dai tempi della sua filosofia pratica, rendere la propria vita perfetta, trasformarla in opera d’arte, ha richiesto disciplina e, spesso, sofferenza. Allora non dovrebbe sorprendere che Slim Aarons, il fotografo che ha immortalato la bella vita del ’900 e che ha (anche) contribuito a definire l’estetica di questo stesso giornale, abbia esordito come fotografo di guerra, documentando lo scontro tra nazisti e Alleati in Europa.

«Sentivo di meritare una vita più semplice e lussuosa come compensazione degli anni in cui ho dormito nel fango, mentre venivo bombardato e colpito da proiettili», dirà Aarons dopo quest’esperienza. Così profonda da farlo diventare un altro: sarà solo dopo la Guerra che il fino ad allora George Allen Aarons diverrà Slim Aarons. Del resto, anche il mare è apparentemente superficiale, eppure sotto il pelo dell’acqua si apre l’abisso. Ed ecco che certe frasi del fotografo non suonano più così superficiali: «Non fotograferò più nessuna spiaggia che non abbia una bionda dentro». In pochi si allenano con la necessaria disciplina per arrivare ad apprezzare la bellezza dell’istante.

Eppure, i soggetti delle foto di Aarons sembrano tutti campioni di epicureismo. A chi gli chiedeva perché sembrassero così felici, lui rispose: «Perché gli piaccio». La verità è che era il suo sguardo a trasfigurare il mondo, era il suo sguardo che pretendeva la felicità. Perché era stato proprio Aarons ad allenarsi ad apprezzare l’istante. Era il suo stesso obiettivo che convinceva la luce a inondare le piscine e i giardini e i corpi dei ricchi di Palm Springs, di Park Avenue, delle Alpi svizzere, di Marbella e Capri. Era il suo sguardo ad accarezzare quei volti soddisfatti e atarassici, a creare felicità là dove, probabilmente, spesso non ce n’era nemmeno l’ombra. Se poi si considera che il piacere, in quanto sensazione, non può essere illusorio (tutt’al più potrà essere illusoria la causa del piacere), i rigidi confini tra mondo reale e Metaverso non sembrano più così rigidi.

Si tratta piuttosto di un processo: la fotografia sta al metaverso come i razzi spaziali stanno alle carrozze. La fotografia ferma il tempo. Nel caso di Aarons, ferma un istante perfetto che, forse, in quella perfezione, non è mai esistito. Le forme del metaverso sono altrettanto incorruttibili, immuni al tempo, con la differenza (non di poco conto), che queste forme adesso possono essere abitate. E però, fuori da lì, il tempo continua a scorrere, inesausto, e i corpi a corrompersi. E pure dentro il metaverso, l’antica domanda di fondo resta immutata: è questo il modo migliore per apprezzare uno degli istanti che mi sono toccati in sorte in numero limitato e imprevedibile?